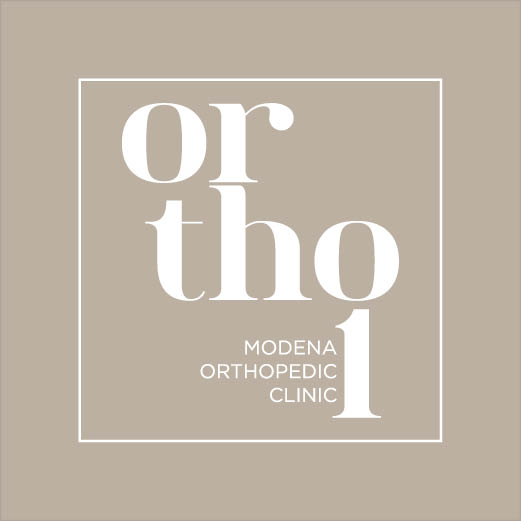Quel maledetto asterisco sul colesterolo! Perché preoccupa tanto e come gestirlo tramite l’alimentazione e l’integrazione
Articolo a cura del Dott. Alessandro Ciocia, biologo nutrizionista.
Il colesterolo è una molecola dalle numerose funzioni all’interno dell’organismo umano: è un componente fondamentale delle membrane cellulari, delle lipoproteine e partecipa attivamente alla modulazione della fluidità della membrana cellulare.
Inoltre, è anche il precursore di numerose molecole bioattive dall’enorme rilevanza fisiologica, tra cui: gli ormoni steroidei (ormoni sessuali e adrenocorticoidi), degli acidi biliari (utili durante il processo digestivo, per assorbire meglio i grassi della dieta) e, in una sua particolare forma chimica, serve alla sintesi di vitamina D (sostanza ad azione ormonale con numerosissimi effetti nel nostro corpo) (Mariani Costantitini, 2016).
Metabolismo del colesterolo e apporto alimentari
Date le importanti funzioni del colesterolo, il corpo umano, possiede la via metabolica per la sua produzione che è in grado di soddisfare in buona parte le necessità dell’organismo, infatti, solo una piccola parte del colesterolo del corpo proviene dalla dieta (ne viene assorbito circa il 50%, ma è un dato che gode di una forte variabilità). Il fabbisogno alimentare di colesterolo, considerando un soggetto adulto e sano è:
- di 300 mg/die per gli uomini
- 224 mg/die per le donne.
La produzione di colesterolo da parte dell’organismo è inversamente proporzionale a quello introdotto con la dieta (SINU, 2024)
Lipoproteine: trasporto del colesterolo
In generale, i lipidi (quindi anche il colesterolo), che siano di derivazione endogena o introdotti tramite la dieta, vengono veicolati alle cellule del nostro corpo tramite l’azione delle lipoproteine. Le lipoproteine sono formate da una parte lipidica (colesterolo, trigliceridi, fosfolipidi) e da una proteica (le apoliproteine) (Mach F, 2020). Le lipoproteine vengono classificate in base alla loro densità (più sono ricche di lipidi e povere di parte proteica, minore sarà la loro densità); le principali lipoproteine nel nostro organismo sono sei: i chilomicroni, le lipoproteine a densità molto bassa (VLDL), le lipoproteine a densità intermedia (IDL), le lipoproteine a bassa densità (LDL); Lp(a) e le lipoproteine ad alta densità (HDL) (Mach F, 2020) (Mariani Costantitini, 2016).
Una trattazione approfondita delle varie lipoproteine è ben aldilà delle intenzioni del presente testo; tuttavia, è bene ricordare che le LDL (note volgarmente come colesterolo “cattivo”) veicolano il colesterolo epatico ai tessuti periferici, mentre, le HDL (note volgarmente come colesterolo “buono” riportano il colesterolo in eccesso al fegato. Queste lipoproteine sono ben note perché molto legate al rischio cardiovascolare, in particolare, avere alterati valori di colesterolo LDL è stato dimostrato essere un fattore causale di malattia cardiovascolare.
È interessante notare come gli studi abbiano confermato che il rischio cardiovascolare cresce in modo proporzionale alla concentrazione plasmatica di colesterolo LDL; e che non è ancora stata definita quale sia la concentrazione di colesterolo LDL sotto la quale questo aumento di rischio non è più rilevabile; pertanto gli scienziati raccomandano: “the lower, the better” (più basso è, meglio è) (Poli A, 2018) (Visioli F, 2019).
È quindi ragionevole ritenere il trattamento dei livelli di colesterolo LDL un obiettivo di primaria importanza, in quanto una riduzione della sua concentrazione, se sufficientemente protratta nel tempo, porterà ad una riduzione del rischio cardiovascolare a prescindere dai valori di colesterolo LDL di partenza; il cui effetto è indipendente dal tipo di intervento utilizzato per ridurre i livelli della lipoproteina. (Poli A, 2018)
Dato il valore causale del colesterolo LDL nella gestione del rischio cardiovascolare, il presente testo è volto a fornire delle informazioni utili per comprendere quali siano le evidenze scientifiche ad oggi disponibili in relazione alla riduzione del colesterolo LDL tramite lo stile di vita e l’approccio integrativo.
Relazione tra colesterolo LDL, i fattori dietetici e lo stile di vita
Molti sono gli aspetti che possono influenzare il metabolismo lipidico e favorire un miglioramento del rischio cardiovascolare. Implementare tali pratiche, secondo le linee guida, contribuisce a migliorare e/o mantenere un buona funzionalità cardiovascolare.
Riduzione del peso corporeo e attività fisica
Le condizioni di sovrappeso e obesità possono alterare il quadro lipidico di un soggetto; la riduzione di peso anche se modesta (5-10% rispetto al peso di partenza), migliora il profilo lipidico e numerosi parametri del rischio cardiovascolare. Tale perdita di peso può essere favorita da un regime dietetico ipocalorico e dall’esercizio fisico di moderata intensità (Mach F, 2020).
Smettere di fumare
Cessare con l’abitudine tabagica migliora il rischio cardiovascolare in generale, nella fattispecie del profilo lipidico, migliora i livelli delle lipoproteine HDL (Mach F, 2020).
Scegliere i corretti lipidi alimentari
Limitare il consumo di grassi trans: questi grassi sono ottenuti dalla parziale idrogenazione degli oli vegetali (spesso utilizzati per la produzione di margarine). Ad oggi, il consumo di questi acidi grassi è fortemente ridotto (Mach F, 2020).
Limitare il consumo di grassi saturi: il loro consumo dovrebbe essere limitato (< 10% delle calorie totali giornaliere) e ridotto ulteriormente in caso di ipercolesterolemia (< 7% delle calorie totali giornaliere) (Mach F, 2020). I grassi saturi sono presenti in numerosi alimenti sia vegetali che animali.
Favorire il consumo di grassi monoinsaturi, omega 3 e omega 6: tra i grassi monoinsaturi il più raccomandato è l’acido oleico (molto abbondante nell’olio extravergine di oliva), mentre, per gli omega 3, sono l’acido α-linolenico, (molto presente in oli vegetali come lino, soia e noci), l’EPA e il DHA (molto abbondanti nei pesci grassi dei mari freddi e in alcune alghe commestibili).
Gli omega 6 (grassi polinsaturi) sono i più diffusi e si ritrovano sia in alimenti vegetali che animali. I più rappresentativi sono l’acido linoleico (molto presente negli oli vegetali e meno nel mondo animale) e l’acido arachidonico, molto abbondante nel mondo animale. È importate mantenere una corretta proporzione tra grassi omega 3 ed omega 6 nella dieta (Mach F, 2020) (SINU, 2024).
Fibre e carboidrati
Scegliere i giusti carboidrati: appare essere una buona strategia per il controllo delle lipoproteine e i trigliceridi plasmatici. In particolare, secondo le linee guida, un consumo eccessivo sembra avere un effetto “neutrale” nei confronti delle LDL, ma sfavorevole nei confronti delle HDL e dei trigliceridi plasmatici (Mach F, 2020). La quantità di carboidrati raccomandata è compresa tra il 45-55% delle calorie totali giornaliere in quanto livelli più elevati o più bassi sono associati ad aumento della mortalità. Particolare attenzione va posta agli zuccheri aggiunti, la loro quantità non dovrebbe superare il 10% delle calorie totali della dieta (in addizione agli zuccheri della frutta o dei prodotti lattiero caseari); limitazioni aggiuntive sono raccomandate in soggetti con elevati trigliceridi plasmatici, sindrome metabolica o diabete mellito. Il consumo di bevande zuccherate gassate (molto ricche in zuccheri aggiunti) è da limitare fortemente nella popolazione generale e soprattutto nei soggetti con elevato rischio cardiovascolare (Mach F, 2020).
Assumere fibra alimentare: Ruolo molto interessante è quello della fibra alimentare, in particolare di quella parte di fibra definita come solubile (in acqua): molto abbondanti in legumi, vegetali, frutta e cereali (l’avena e l’orzo ne sono ottimi esempi) in quanto possiede effetti ipocolesterolemizzanti ben documentati. Includere nella propria dieta apporti di fibra solubile uguale o maggiori di 7-13 gr al giorno, rappresenta una buona strategia per mantenere sotto controllo i livelli di lipoproteine LDL (Mach F, 2020).
Consumo di alcol
Il consumo moderato di alcol, ovvero ≤ 10 gr di alcol giornalieri (circa un bicchiere di vino o una birra da 33 cl) sia per l’uomo che per la donna è accettabile, a patto che i livelli di trigliceridi siano nella norma (Mach F, 2020).
A scopo prettamente indicativo, si riporta una tabella utile a capire quali possano essere gli alimenti da preferire e quali meno, per gestire i propri livelli di lipoproteine.
Rivalutazione dell’intervento nutrizionale sul colesterolo LDL
Recentemente, il ruolo dell’intervento nutrizionale è stato rivalutato. In passato, il suo effetto, secondo numerosi ricercatori, è stato fortemente sovrastimato.
Recenti studi hanno evidenziato come le classiche raccomandazioni dietetiche atte a ridurre il colesterolo portino ad una riduzione molto piccola (dal -1.5 al 5%) del colesterolo LDL, senza contare che seguire una dieta sul lungo periodo è difficile e spesso si perde motivazione (Poli A, 2018).
Limitazioni degli interventi dietetici classici
Come recentemente evidenziato, ridurre il carico dietetico degli acidi grassi saturi, anche se in grado di abbassare i livelli di colesterolo LDL, non appare sufficiente a modificare il rischio cardiovascolare o la mortalità per tutte le cause. Anche gli altri interventi dietetici proposti sembrano non possedere grossi effetti sul colesterolo LDL; piuttosto, svolgono un ruolo preventivo nella gestione del rischio cardiovascolare in generale.
Assumere corretti quantitativi di fibre, assumere buone dosi di polifenoli (sostanze anti-infiammatorie e anti-ossidanti), assumere adeguate quantità di acidi grassi polinsaturi (anti-infiammatori, anti-trombotici e antiaritmici) e svolgere regolare attività fisica (miglioramento funzione endoteliale, miglioramento stato ossidativo ecc) sono in grado di migliorare il rischio cardiovascolare in maniera indipendente dall’effetto sul colesterolo LDL (Poli A, 2018).
Applicazione delle raccomandazioni anche a soggetti sani
Pare quindi evidente che le raccomandazioni poco sopra citate, oltre che ai soggetti con un profilo lipidico alterato, debbano essere proposte anche a soggetti in cui tali alterazioni non sono presenti (Poli A, 2018).
Alla luce dell’effetto non particolarmente efficace dello stile di vita nella gestione del colesterolo LDL, i ricercatori suggeriscono l’adozione anche di altre strategie utili alla normalizzazione dei suoi livelli, quali: l’approccio farmacologico e quello integrativo (Poli A, 2018). Non si affronterà la questione farmacologica, aldilà dello scopo di questo testo, ma, nella prossima sezione, si illustreranno le principali sostanze ad azione nutraceutica utili per il controllo del colesterolo.
Integratori alimentari e colesterolo
Steroli e stanoli vegetali
Sono noti anche con il termine di fitosteroli, ne sono state identificate più di 250 molecole e il β-sitosterolo risulta il più presente negli alimenti. I fitosteroli, volgarmente definibili “colesterolo vegetale”, sono molti abbondanti nel mondo vegetale (alimenti molto ricchi sono: gli oli vegetali, frutta secca, cereali e derivati, cavoli, cavolfiore e olive verdi e nere) e praticamente assenti nel mondo animale. Possiedono un’analogia strutturale con il colesterolo animale, l’unica differenza, è la presenza di un gruppo etile su uno degli atomi di carboni della molecola, il che è in parte responsabile dello scarso assorbimento intestinale dei fitosteroli (Visioli F, 2019) (Poli A, 2018).
Il meccanismo di azione dei fitosteroli è di natura competitiva: avviene una competizione tra i fitosteroli e il colesterolo per essere inclusi nelle micelle che verranno poi assorbite a livello intestinale. I fitosteroli, essendo più facilmente idrolizzabili, tendono ad “entrare” nelle micelle con maggiore facilità e questo comporta una ridotta assunzione di colesterolo ed una sua maggiore escrezione tramite le feci. Nell’ottica di ottenere un buon effetto ipocolesterolemizzante, sono necessari almeno 1.5 g al giorno di fitosteroli, anche se già i pochi milligrammi ottenibili tramite una buona dieta Mediterranea o vegetariana possono sortire qualche effetto. (Visioli F, 2019) (Poli A, 2018)
La riduzione dell’assorbimento di colesterolo intestinale mediato dai fitosteroli comporta una compensatoria produzione del recettore del colesterolo LDL da parte delle cellule del fegato e questo si traduce in una riduzione del colesterolo circolante dovuto ad una maggiore captazione da parte del fegato. I fitosteroli non hanno alcun effetto sui livelli del colesterolo HDL e i trigliceridi (Poli A, 2018). Per ottenere il massimo dell’effetto dai fitosteroli, gli alimenti funzionali e gli integratori che li contengono, devono essere assunti duranti i pasti principali, proprio nel momento in cui il colesterolo, sia quello derivante dalla dieta sia quello derivante dalla secrezione biliare, sono presenti al massimo delle loro concentrazioni nell’intestino (Poli A, 2018) (Visioli F, 2019). Il consumo regolare di fitosteroli può ridurre l’assorbimento di alcuni carotenoidi e di vitamine liposolubili. È consigliato aumentare la quota, tramite la dieta, di frutta e verdura per prevenirne la carenza (Poli A, 2018).
Riso rosso fermentato
Un altro diffusissimo supplemento utile per la gestione dei livelli di colesterolo è il riso rosso fermentato, il quale deriva dalla fermentazione del riso, operata dal fungo Monascus purpureus, che produce il tipico colore rosso e una serie di molecole capaci di inibire la sintesi di colesterolo a livello del fegato (Poli A, 2018) (Visioli F, 2019). Tali molecole sono note come monacoline; la più efficace è la K, le altre presenti possiedono un effetto molto minore sul colesterolo (Poli A, 2018).
L’effetto della monacolina K è dovuto ad una completa somiglianza, in termini chimici, con la lovastatina (statina) farmaco in grado di limitare l’attività dell’enzima chiave della via di sintesi del colesterolo (HMG-CoA reduttasi). Il dosaggio efficace di monacoline K per la riduzione del colesterolo LDL è compreso tra i 3 e 10 mg al giorno. L’effetto sul colesterolo HDL è trascurabile, invece, i trigliceridi, possono subire una buona riduzione se il loro livello di partenza è particolarmente elevato, in caso contrario, l’effetto risulta molto modesto (Poli A, 2018) (Visioli F, 2019).
In generale il riso rosso (come buona parte degli integratori) è percepito dalle persone come alternativa più “naturale” rispetto ai farmaci e quindi meglio tollerabile in termini di effetti collaterali. Tuttavia, si ricorda che la monacolina K possiede un’analogia strutturale con la lovastatina che è un farmaco; i soggetti che hanno sperimentato intolleranza alle statine potrebbero presentare la medesima intolleranza alla moncolina K dal momento che la molecola è strutturalmente identica (Poli A, 2018). Infatti numerosi sono stati gli eventi avversi alla monacolina K da riso rosso fermentato segnalati, alcuni dei quali anche gravi (rabdomilisi, danni epatici, mialgia e/o un aumento di creatina chinasi (CK), tutti eventi avversi tipici delle statine) (Poli A, 2018).
Tanta la preoccupazione per tali episodi, che l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ha effettuato una rivalutazione del claim salutistico: “la Monacolina K da riso rosso fermentato contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue”. Il panel di esperti che ha effettuato tale rivalutazione, ha evidenziato “che le monacoline da riso rosso fermentato al dosaggio d’uso di 10 mg/giorno destano preoccupazioni significative in materia di sicurezza”, inoltre, sono stati anche registrati “singoli casi di reazioni avverse gravi per le monacoline K da riso rosso fermentato a livelli di assunzione di appena 3 mg/giorno”. L’EFSA non è quindi stata in grado di determinare la dose di assunzione giornaliera scevra da rischi per la salute. Inoltre, il comitato scientifico di EFSA, ha sottolineato l’incertezza circa la composizione e il tenore di queste monacoline negli integratori, senza contare che spesso sono presenti altri ingredienti attivi, i cui componenti non sono stati adeguatamente valutati singolarmente o in combinazione (Europea, 2024) ((ANS), 2018).
Prendendo atto del parere di EFSA, la Commissione Europea, si è vista costretta a ritirare il claim salutistico nei confronti della monacolina K e di non permettere la commercializzazione di integratori di riso rosso fermentato con un contenuto di monacoline pari o superiore a 3 mg (Europea, 2024).
Questo è un dei tanti fatti utili a sfatare il mito del “naturale è meglio”.
I Beta – glucani e le fibre
Un adeguato apporto di fibra è associato a numerosi benefici nei confronti della salute, aldilà dell’effetto sul colesterolo LDL (Visioli F, 2019). Le fibre sono classificate come carboidrati complessi che non vengono digerite nel tratto gastrointestinale (rimangono intatte) e hanno dimostrato effetti benefici nei confronti dei livelli di colesterolo LDL. Il meccanismo di azione non è stato ancora chiarito completamente, ma pare essere dovuto ad una maggiore escrezione tramite le feci di colesterolo alimentare, di bile, e altri grassi alimentari. In generale, gli effetti più sostanziali sulla colesterolemia, si sono ottenuti con le fibre solubili in grado di assorbire acqua e creare una massa molto simile ad un gel nell’intestino, responsabile degli effetti sul colesterolo (Poli A, 2018).
Tra le fibre solubili, i beta-glucani sembrano essere i più efficaci in tal senso. Questo tipo di fibra è molto presente in avena e orzo, ma è anche disponibile in integratori o alimenti fortificati (Poli A, 2018). Le fibre solubili sono in grado di abbassare il colesterolo LDL di 5-6% alla dose di 3 g al giorno, senza particolari effetti sui livelli plasmatici degli altri lipidi. (Poli A, 2018) (Visioli F, 2019). Anche altre fibre come il glucommanano, lo psillio e il chitosano hanno dimostrato effetti simili (Poli A, 2018).
Inoltre, i beta-glucani, hanno dimostrato altri effetti molto interessanti: sono in grado di rallentare la velocità di assorbimento del glucosio intestinale, ritardando la sua entrata nel torrente circolatorio e sono anche fibra prebiotica, cioè funge da nutrimento ai microrganismi positivi per la salute presenti all’interno del tratto intestinale (Poli A, 2018).
Berberina
È una sostanza estratta dalla radice di alcune piante orientali della famiglia delle Berberis. È stato dimostrato che la berberina è in grado di ridurre il colesterolo LDL, mediamente, del 10-20% e di migliorare i livelli di colesterolo HDL, trigliceridi e anche della glicemia (Poli A, 2018). Pare che la berberina possieda diversi meccanismi d’azione anche se ancora non del tutto delucidati (Poli A, 2018).
La berberina sembra agire sia sulla riduzione dei livelli plasmatici di una particolare proteina, ovvero, PCSK9 (una proteina in grado di indurre la degradazione del recettore epatico del colesterolo LDL) sia sul recettore stesso delle LDL, stabilizzando la sua presenza sulle cellule del fegato. Ottenendo, pertanto, un effetto sinergico di aumento della presenza del recettore per le LDL a livello epatico e un aumento della captazione di colesterolo LDL da parte del suo recettore (Poli A, 2018) (Visioli F, 2019).
La berberina, quando somministrata per bocca, possiede uno scarso assorbimento intestinale (1-3%) (Visioli F, 2019) (Poli A, 2018) e questo può portare a risposte metaboliche molto differenti (Poli A, 2018); sono in studio formulazioni volte a migliorare la biodisponibilità della molecola. Alcuni autori auspicano, successivamente all’introduzione di formulazioni più funzionali, una rivalutazione di potenziali effetti collaterali. Ad oggi, il dosaggio di berberina compreso tra 500-1500 mg al giorno sembra non destare preoccupazioni in termini di sicurezza. (Visioli F, 2019)
Altre sostanze ad azione ipocolesterolemizzanti
Nel corso degli anni, la ricerca scientifica si è fortemente concentrata nel trovare nuove molecole che potessero avere degli effetti sui livelli di colesterolo e numerose sostanze sono state identificate a tale scopo; tuttavia, le evidenze sulla loro efficacia, sono ancora oggetto di ricerca da parte della comunità scientifica. Nonostante ciò, queste molecole rimango di grande interesse nell’ambito della nutraceutica (Poli A, 2018).
I derivati della soia sono stati molto studiati in tal senso. I loro effetti sembrano essere dipendenti dal contenuto di isoflavoni, lecitine e proteine in grado di stimolare la presenza dei recettori per il colesterolo LDL. Tuttavia, gli effetti sulla colesterolemia sono molto modesti e necessitano di quantitativi dell’ordine dei grammi (25 g/giorno).
Molto interessanti sono anche le sostanze fenoliche presenti negli alimenti vegetali. Recenti studi hanno evidenziato degli effetti sulla riduzione del colesterolo LDL. Alcuni lavori svolti in Asia, hanno evidenziato che estratti di quercitina (molto abbondante in cipolle, radicchi, foglie di finocchio e le mele) possiedono buoni effetti nei soggetti con elevato rischio cardiovascolare. Anche in Italia, studi del genere, utilizzando estratti di mela Annurca o di Bergamotto, hanno ottenuto dei buoni risultati sia su pazienti con profilo lipidico alterato sia su soggetti con sindrome metabolica. L’esatto meccanismo d’azione delle sostanze fenoliche deve essere ancora compreso; si ipotizza che alcune frazioni fenoliche possano fungere da inibitori dell’enzima chiave (HMG-CoA reduttasi) nella via di formazione del colesterolo.
I policosanoli, derivati dalla canna da zucchero o dalle patate, in studi condotti negli anni 90 avevano dato risultati promettenti in studi condotti a Cuba; ad oggi, sono considerati del tutto inefficaci sui livelli di colesterolo LDL.
Anche i probiotici sono stati suggeriti come agenti in grado di ridurre il colesterolo LDL, tuttavia, l’analisi dei singoli probiotici, ha evidenziato che la maggior parte dei ceppi è inefficace; alcuni effetti positivi sono stati evidenziati da studi che hanno utilizzato combinazioni di probiotici (Poli A, 2018). Ad oggi, l’uso dei probiotici come agenti ipocolesterolemizzanti rimane teorico; la comunità scientifica evidenzia la necessità di ulteriori studi per comprendere se i probiotici possano essere usati in tal senso (Visioli F, 2019).
Bibliografia
- (ANS), E. P. (2018). Scientific opinion on the safety of monacolins in red yeast rice. EFSA J., 16(8):e05368.
- Europea, C. (2024, agosto 12). Ministero della Salute. Tratto da https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=6628
- Mach F, B. C. (2020). ESC Scientific Document Group. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J., 1;41(1):111-188.
- Mariani Costantitini, C. T. (2016). Alimentazione e Nutrizione Umana. Roma: Il Pensioero Scientifico Editore.
- Poli A, B. C. (2018). Nutraceuticals and functional foods for the control of plasma cholesterol levels. An intersociety position paper. Pharmacol Res, 34:51-60.
- SINU. (2024). LARN – Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione Italiana – Revisione V. Milano: BioMedia editore.
- Visioli F, P. A. (2019). Prevention and Treatment of Atherosclerosis: The Use of Nutraceuticals and Functional Foods. In B. C. von Eckardstein A, Prevention and Treatment of Atherosclerosis: Improving State-of-the-Art Management and Search for Novel Targets . Springer.